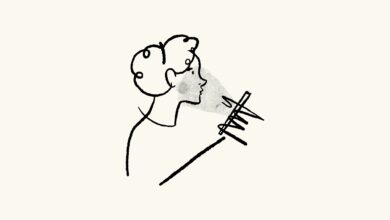L’arte di essere femministe: “dobbiamo essere nude per entrare in un museo?”
di Marzia Figliolia
Nel non lontano 2016, Milo Yiannopoulos, allora direttore del blog della “destra alternativa” americana Breitbart News, lanciò un sondaggio su Twitter:
“Preferiresti che tuo figlio avesse il femminismo o il cancro?”
Chiamato a rispondere di tale affermazione, Yiannopoulos non solo non se ne giustificò, ma rincarò la dose, commentando che solo il 7% delle donne inglesi si ritiene femminista: “Il femminismo esiste solo sui giornali, ormai”.
Mentre Yiannopoulos e il suo team lavorano sodo per riportare il discorso sulla parità di genere indietro di cinquant’anni, esiste un altro ambito, oltre al giornalismo, in cui il discorso femminista è più vivo che mai (e lotta insieme a noi): l’arte.
Ora, il femminismo non è roba da donnette acide e insoddisfatte, che vogliono rubare il lavoro agli hard working men di ogni angolo del globo: la questione femminista nell’arte è nata, se vogliamo, da un dubbio matematico.
Nel 1971, la storica dell’arte Linda Nochlin pubblica un libretto dal titolo Perché non ci sono state grandi artiste?
In realtà, la domanda sottintende, provocatoriamente, una parità di condizioni che non c’è mai stata: fattori economici e pregiudizi sociali hanno sempre fatto in modo che le donne fossero le modelle, e solo raramente le artiste. Il critico John Berger, affrontando la questione solo un anno dopo, concluderà: “Gli uomini hanno sempre guardato le donne. Le donne si sono sempre viste attraverso lo sguardo degli uomini”.
Già a partire dagli anni ’60, però, artiste come Yoko Ono, Lynn Hershman, Hannah Wilke, Lynda Benglis hanno combattuto questa visione maschiocentrica del mondo dell’arte ribaltando l’utilizzo di ciò che fino ad allora le aveva tenute in un angolino, in posa, preda dell’occhio del pittore: il loro corpo. Con la video-arte e la performance, territori ancora poco praticati dai loro colleghi, le donne hanno trasformato ciò che le rendeva muse intoccabili in una materia viva, con cui non essere arte, ma fare arte.
Nella sua iconica performance del 1964, Meat Joy [1], Carolee Schneemann celebra la nuda carne come materiale creativo: l’artista chiedeva al pubblico di partecipare, utilizzando i corpi dei performer come una tela, su cui “dipingere” utilizzando carni di pesci, polli, salsicce, pittura fresca, plastica, pezzetti di carta.
Nel 1979, Judy Chicago imbandì la sua famosa tavola triangolare per 39 storiche figure femminili, nella sua installazione Dinner Party.
Negli anni ’80, mentre il discorso femminista si espandeva dall’ambito artistico a quello sociale e politico, nacquero le Guerrilla Girls, attive ancora oggi, con i loro messaggi di protesta scritti su giganteschi cartelloni apposti fuori i più grandi musei americani. Come quello, famosissimo, che affrontava il problema del Met Museum, in cui l’85% dei nudi esposti erano femminili, ma solo il 5% degli artisti scelti per esporre erano donne: “Ma bisogna proprio essere nude, per entrare in un museo?” si chiedevano e, soprattutto, chiedevano le artiste.
Queste donne e molte altre, non solo hanno lastricato la strada per le generazioni a venire, ma hanno anche spinto le istituzioni a fare scelte non sessiste quando si è trattato di formare nuove collezioni di musei, o di scegliere quali artisti mostrare nelle esposizioni temporanee.
Ciò ha portato probabilmente il discorso femminista ad essere meno pressante, meno pervasivo, forse, negli ultimi anni. Molte nuove artiste lavorano su problematiche avvertite come personali, più che collettive. Ma se ciò è possibile, è solo perché il movimento femminista, nell’arte, è esistito, esiste, ed è ciò che permette alle donne della nuova generazione di potersi esprimere liberamente, così liberamente da scegliere di non doversi considerare a tutti i costi femministe.
Ditelo a Milo Yannopoulos, grazie.
[1] Gioco di parole che può significare “piacere della carne”, ma suona anche come “meet joy”, e cioè “incontra la felicità”