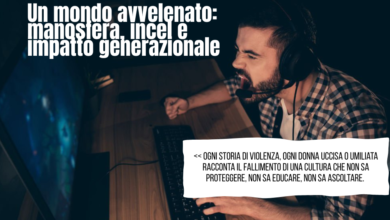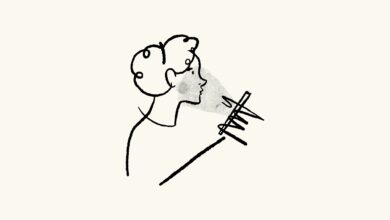Inciuciare in incognito
Per un genitore, scegliere il nome adatto per i propri figli è sempre un’ardua impresa: c’è chi si lascia influenzare dal fascino esotico dei nomi stranieri e chi, fedele alla tradizione della supponta, ripercorre tutti i gradi dell’albero genealogico della propria famiglia per non scontentare nessuno.
Il nome giusto, però, non esiste, ed è per questo che nasce una delle regole non scritte della napoletanità, una legge che tutti applicano spontaneamente senza che gli sia stata spiegata: l’arte del soprannome.
Il soprannome, il nomignolo o come si dice a Napoli ‘o contrannomm’ è quell’appellativo che in una sola parola racchiude al meglio la personalità della persona a cui viene attribuito. Per quanto il nome di battesimo possa avere un significato particolare per i genitori che l’hanno scelto, esso non dirà mai nulla sulle effettive caratteristiche fisiche, caratteriali o comportamentali della persona a cui è stato dato; è qui che interviene il nomignolo.
E non è certo una sciocchezza, se persino Philip Roth ha usato questo stratagemma per il personaggio su cui è incentrato uno dei suoi capolavori meglio riusciti: Seymour Levov, lo “Svedese”.
Capelli biondi, occhi blu, di bell’aspetto, palesemente nordico, rigoroso nella sua compostezza, eccellente in ogni cosa facesse – dallo sport in cui era campione al lavoro che dirigeva sapientemente: quale nome meglio dello “Svedese” sarebbe stato in grado di rappresentare la personalità di un uomo così maestosamente perfetto, tanto devoto a quel sogno americano che ha inseguito durante tutta la sua vita?
Ma da Pastorale Americana passiamo ora a Genialità Napoletana.
Tutti a Napoli hanno un soprannome. In ogni singolo paese, in ogni cittadina che conti un numero abbastanza ristretto di abitanti da avere almeno un nomignolo per ogni famiglia, i cognomi vengono sostituiti da quegli appellativi che, una volta affibbiati, vedono i soggetti costretti, nel bene e nel male, a portare fin sulla lapide. Non è raro, infatti, trovare sui manifesti funebri che tappezzano la città, oltre al nome e cognome del defunto, il fatidico soprannome.
“È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Andrea Iervolino, di anni 86, detto Uocchieargiento”.
“Serenamente si è spenta la cara esistenza di Gigliosetto Pasquale, di anni 78, detto ‘o Riavulillo”.
“Improvvisamente si è spento il signor Domenico Improta, di anni 28 (detto Mullchell)”.
Parlo di questi tristi annunci perché sono forse l’unica traccia scritta di questi nomignoli, che solo chi vive la quotidianità di un piccolo borgo cittadino può conoscere e comprendere interamente, custodendone gelosamente la memoria tramandandone l’usanza.
Se cresci in un ambiente in cui dare nomignoli a qualsiasi persona si conosca è la prassi, diventa difficile disabituarsi dal farlo, più di quanto sia stato complicato inizialmente imparare a riconoscerli tutti.
Ricordo quando, da piccola, venivo mandata a comprare qualcosa di urgente da mia nonna, che non conosceva il nome dei negozi del paese, ma sapeva chi fossero i loro proprietari e li chiamava con i loro soprannomi, ovviamente.
“Rebbè, sient’ ‘a nonna, vai adde Facc’ Rosse e compra ‘nu miezzu chil’ ‘e pane”
…e mmò chi so’ ‘sti facce rosse?
Chiedere spiegazioni sarebbe stato un sacrilegio, un affronto, un atto di infedeltà. Figuravo nella mente lo sguardo deluso della nonnina, che con sdegno si sarebbe rivolta a mia madre, già con la fronte corrugata, sentenziando: “Figl’t nun è nipot’ a mme”.
E così, pur di evitare di essere disconosciuta dalla mia famiglia, mi incamminavo con quei cinque euro in mano – di cui potevo tenere il resto per prendermi un gelato‘ché sto sempre sciupata – e andavo alla ricerca di quel luogo mistico.
Effettivamente, devo riconoscerlo, non era difficile ma praticamente impossibile cadere in errore: quello era l’unico supermercato che si potesse raggiungere a piedi in poco tempo. Eppure, notai con una certa soddisfazione per le mie capacità deduttive da bambina, che, viste le persone che lavoravano lì, non mi ero sbagliata: non avrebbero potuto avere un soprannome più azzeccato, date le loro guance arrossate, 365 giorni l’anno, talvolta per il freddo, talvolta per il troppo caldo.
Dunque, a un certo punto mi resi conto di non conoscere i veri nomi di nessuno del mio paese, perché per me erano Occhialett’, Titinaell’Ov’, ‘o Rentill, Tore ‘a Cantin, Rafel ‘a Scella e via dicendo, soprannomi manifestazione di una forte identità e connessione con la persona a cui si riferivano, un legame inscindibile, un vero e proprio titolo, il cui utilizzo non era facoltativo ma assolutamente necessario, per farsi capire e per far parte di quell’ambiente.
Viene così a crearsi un linguaggio in codice, un vocabolario che ben si presta alle esigenze delle più cufecchie, che adoperandolo possono darsi all’inciucio senza il timore di essere capite o ascoltate da qualcuno, che non potrebbe mai arrivare a dedurre i veri soggetti dei loro discorsi.
L’ingegno della ‘nciucessae la sonorità del napoletano rendono la scelta del nomignolo un momento sacro e definitivo, il rito che sancisce l’unione inviolabile di quella persona con il suo soprannome: riuscire a trovare quello giusto è un’arte, applicarla senza farsi decifrare un talento che pochi hanno.
“È venut ‘o scartellat’?”
“Oillann’”
“E ‘o Pisciat ‘ngap?”
“Sta llà”
“…non vedo ‘o spicchiat’”
“Sta qua… no, nun ce pozz’ crer’r… o’ spicchiat’ sta senz e lent’… e mo?”
Rebecca Grosso
Leggi anche: Il corredo: retaggio del passato o una tradizione che persiste?