Segnale d’allarme: Elio Germano e la politica dell’assurdo
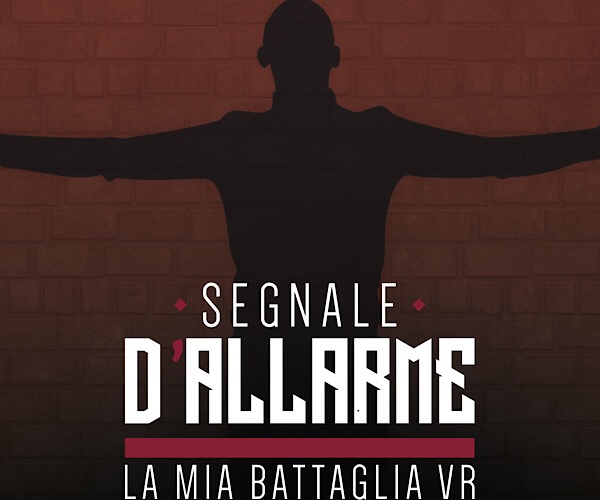
Uno dei primissimi esperimenti mondiali di teatro in realtà virtuale approda in Italia. Si chiama Segnale d’allarme, porta la firma di Elio Germano e vi manipolerà straordinariamente in 70 minuti.
Elio non c’è. O meglio, non è fisicamente presente in sala. Ma lo sapevamo, la brochure dello spettacolo lo specificava: una “battaglia” in VR, un gioco metateatrale intrecciato allo sperimentalismo virtuale. Questa chirurgia drammaturgica viaggia tra i palchi vuoti dei teatri italiani non senza lo scetticismo di una platea vergine, spettatrice dell’assenza del “giovane favoloso”, di una performance vissuta nello spazio illusionistico di un visore. Ma tu siediti, infila pure le cuffie, attiva quella maschera da sub troppo ingombrante per il tuo viso e vedrai come – nel giro di 70 minuti – Elio saprà entrarti nella testa, subdolamente, strimpellando le corde della tua mente pigra, armato di sole parole e provocazioni, lì a solleticarti la coscienza in differita.
Immagina di indossare queste lenti d’avanguardia e di approdare in prima fila allo Spazio Tondelli di Riccione, tu spettatore-fantasma di questa performance che frega le logiche del tempo e logora le distanze, immerso in una platea del passato dove risate e plausi si mischiano alle reazioni immediate, presenti, di te infiltrato dal futuro che sei assente, seduto su una poltrona vuota. Elio irrompe in sala a sorpresa, energicamente, piombando dalle spalle del pubblico “come il peggiore degli incubi”, insinuandosi a gamba tesa nello spazio intimo e affollato di questo private show, come un ologramma tutto muscoli tesi e parole taglienti che scivola tra le file di velluto rosso. Ragionare: questo il fine “estremo” di un soliloquio dai contenuti “forti”, una performance cerebrale dai risvolti inquietanti, a detta del Germano, che sa molto di “emotional preparation” prima di andare in scena, quel rituale dei sentimenti necessario agli attori prima di un ciak. Oppure proprio come nell’incipit di un film violento che recita “attenzione: queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità” per metterci al riparo dai suoi contenuti proibitivi. Si tratta di “un’ora di paura e poi via, a mangiare, a ballare, a fare l’amore – per chi ancora ne avrà voglia”.
Elio viaggia con le parole e quasi non gli si riesce a star dietro. Dalla tecnologia che è simultaneamente intelligenza e deficienza di contatto carnale e presenza emotiva, a un sistema educativo che pecca di concretezza, che ci bombarda di nozioni astratte e ci priva di competenze specialistiche. Per poi passare alla scarsa coscienza politica dell’elettorato italiano, incapace di problematizzare l’attualità – perché ormai l’audacia di un “io credo” costa fatica e porta con sé i caratteri dell’eccezionalità – manipolato da una demagogia posticcia, fraudolenta, che orienta i nostri desideri con l’ipocrisia strisciante della parola e che si piega a qualsiasi compromesso ideologico pur di guadagnarsi il consenso popolare. E il Made in Italy di lusso svilito dall’esterofilia? Quante le maison-simbolo del “bel paese” vendute ad arabi e cinesi? Tante, troppe. E questa manovalanza dalla pelle ambrata e la mano pronta che ci ruba il lavoro? Che rimpiazza i nostri ragazzi quattrocchi, gracilini, dalle ossa di vetro, che dalle trincee delle loro scrivanie, a sguardo basso e schiena ricurva, battagliano con codici di diritto piuttosto che con la brutale competitività di un mondo lavorativo troppo spietato.
In un’escalation di luoghi comuni e orgogliose rivendicazioni nazionaliste, pronunciate con una verve che fa gonfiare le vene sul collo e sciogliere il pubblico in applausi sfrenati, fanno capolino termini come “matrimoni misti”, “italianità”, “razza”, “ebrei”. Ed è proprio nella severità di questa retorica da pulpito e nella scelta lessicale – affatto casuale – di un discorso così spregiudicato nella sua autorevolezza , che si innesca un sinistro estraniamento del nostro spettatore: è l’inizio della fine. Quella che sembrava una riflessione urgente, lucida – per quanto spiazzante nella sua sincerità – dello spirito del nostro tempo, si palesa nella sua intricata architettura di logiche meschine e manipolatorie. In uma climax di violenza verbale e gestualità plateali, esasperate dalla quasi ovazione di un pubblico che cavalca – visibilmente entusiasta – quest’ondata oltranzista, sprofondiamo nella cupa Germania del secolo breve, senza fare neppure un passo indietro nel tempo. Il simbolo di una svastica, poi un esercito di attori – gli stessi ad applaudire poco prima – che in una processione della morte si staccano dal pubblico, ed è subito luce. È lo svelamento totale di um meccanismo scenico perfetto, che ha trascinato il pubblico nelle trappole della politica, in un’inquietante deriva conoscitiva.
In questo dialogo insonorizzato con l’intimità, immersi nell’individualismo virtuale, siamo chiamati a riconoscere la fallibilità del nostro giudizio. Nessuna possibilità di uniformarsi ad un plauso collettivo, nè ad una risata contagiosa del nostro vicino di poltrona. Lo spettatore senza tempo, dalla sua maschera futuristica, viene invitato a interrogarsi solipsisticamente sugli effetti devianti degli “opinion leaders”, che, una volta identificati, ci rendono schiavi delle loro sentenze perentorie. Bisogna interrogarsi sulla bontà delle mode collettive prima di aderirvi, sviscerare il marcio dagli slogan politici, capirne il significato, come prima di lasciarsi andare ad un applauso troppo rumoroso di cui non abbiamo ben compreso il senso.
Elio Germano in 70 minuti ci insegna che plasmare il Mein Kampf di Hitler sulle logiche chimeriche di un presente imperfetto è roba da dilettanti. Che i famosi ricorsi storici sono a un passo dalla realtà e che scegliere con cura le parole da (non) dire può cambiare le sorti di quest’umanità così cedevole alle passioni violente e alla banalità del male.
Francesca Eboli
Vedi anche: Apologia di Alexi Kaye Campbell al Teatro Mercadante: Elisabetta Pozzi e la parola




