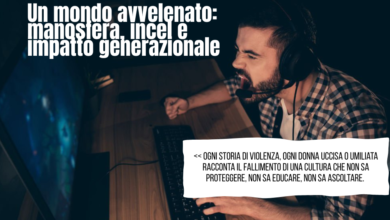I can’t breathe. E nemmeno noi, George.
I can’t breathe. I can’t breathe. Please, help. Give me some water or something. Please, man. I can’t breathe.
My stomach hurts.
My neck hurts.
Everything hurts.
They’re going to kill me.
Le ultime parole di George Floyd, schiacciato al suolo dal ginocchio di un policeman di Minneapolis, determinatamente fermo sul suo collo inerme, a pochi millimetri dalla carotide, resteranno nella memoria delle masse per molto tempo.
Spero. Lo spero davvero.
Non deve essere solo un altro incidente, solo un altro uomo afroamericano ucciso dalla polizia americana che – si sa – ce l’ha per abitudine. Perché è cultura e storia americana e ciò che succede in America è sempre esagerato, assoluto, mitico.
L’America è un film, anche nelle manifestazioni di vita piccole, quotidiane. L’esaltazione di ogni cosa priva di significato un po’ tutto, finché non ci si sbalordisce davanti a nulla, nemmeno avanti ad eventi che dovrebbero scuotere la civiltà umana sin nel midollo, nella sua componente più fondamentale.
La storia o – per meglio dire – la fine della storia di George Floyd, quarantaseienne di Minneapolis fermato per frode da alcuni agenti locali, potrebbe correre il rischio di diventare una di quelle favole urbane che gli americani sanno trasformare benissimo in tragici film, tanto realistici quanto strappalacrime. Potrebbe vincere uno, due, tre Oscar, essere diretto da Steve R. McQueen o da Spike Lee. La storia perfetta per un documentario a puntate prodotto da Netflix.
E invece no, non dovrebbe. Non dovrebbe essere edulcorato, o mitizzato, o raccontato. Non bisogna attribuirgli una morale o un principio da tramandare ai posteri. L’accaduto è stato già filmato, diffuso, condiviso.
La morte di George Floyd, molto reale, molto banale, insignificante e terribile, è stata già spettacolarizzata. I social già pullulano di fotografie, disegni, filmati, meme : è stata già assimilata, normalizzata. È un fenomeno social ed è così che viene accettata, ma è anche così che ha viaggiato per i continenti, per le culture, per le storie. Così ha indignato il globo intero, nella sua crudezza, nella sua verità. La poesia che si crea attorno è una sovrastruttura di cui l’uomo ha bisogno per processare, darsi una spiegazione, trarre un insegnamento o una speranza.
Non c’è nulla da dire o da provare se non l’indignazione, la necessità imperativa di una giustizia feroce ed equa per un omicidio a sangue freddo, volontario e consapevole. E qui nasce davvero la domanda, il dubbio che ci sembra paradossale ed incredibile porci: quanto potere è giusto che un corpo di forze dell’ordine abbia? Quanta libertà e quanta onnipotenza può un uomo in carne ed ossa, mortale e fallibile, sentire in sé per uccidere un altro uomo davanti a persone spaventate che lo filmano per condividere con il mondo intero la sua barbarica impresa?
Con che coraggio e sicurezza mostri il tuo volto alla camera del cellulare mentre tieni il tuo aguzzo ginocchio sul collo di un uomo morente per 5 minuti?
Quanta forza, quanta presenza di spirito ci vuole per mantenere fermo ed ammazzare un uomo così grosso? Un buttafuori.
Senza battere ciglio, senza sgomento o fatica, circondati da persone indifferenti, colleghi poliziotti che deambulano serenamente, sicuri nelle loro fortezze, nelle loro uniformi da intoccabili. Questo è il ritratto della polizia dipinto dal video: quello di un’arma senza onore, ignara della propria mortalità e della finitezza, della coscienza che si presupporrebbe essere in esubero in chi ha scelto di servire e proteggere, così tanta da poterne distribuire al prossimo. Tutto quello che vediamo, invece, è un profondo cancro che non sembra frutto se non del potere, il potere di sentirsi più che un uomo, superiore, giustificato, in diritto ed in dovere. L’essere umano ed il potere sono nemici, il loro un rapporto di profonda corruzione, rovina, cupidigia e delirio.
L’indignazione può riscattare questa cultura, questo inutile delirio di onnipotenza e riportare l’umanità, la difesa ed il rispetto di ogni vita, almeno in chi dovrebbe esserne l’emblema ?Per ora, noi non riusciamo a respirare. WE CAN’T BREATHE.EVERYTHING HURTS.
Sveva Di Palma