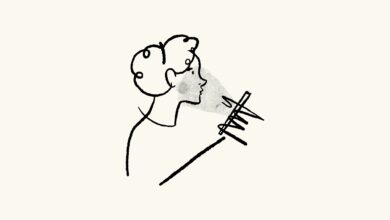The Savanna Theory of Happiness: elogio felice alla solitudine

«La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza».
Così scriveva Pasolini nel 1969 nella rubrica “Caos” per la rivista Il Tempo illustrato, un confessione scritta con mani tremanti in un momento di terrore, un elogio sottile agli spiriti inquieti come lui, allergici alle “greggi ideologiche” e pacificati nel solitario amoreggiare con la propria “provocatoria indipendenza”.
Lui la descrive come un vizio, una reminiscenza sbiadita di quella “perfetta solitudine goduta nel ventre materno”, che si addice solo agli animi più forti e saldamente ancorati alla complessità della loro sostanza emotiva.
Ed è proprio sul concetto di solitudine che vogliamo soffermarci qui, filtrandolo attraverso l’analisi di due psicologi evoluzionisti (Satoshi Kanazawa della London School of Economics e Norman Li della Singapore Management University), divulgata nel 2016 dal British Journal of Psychology. Uno studio che ha anatomizzato in modo inedito la qualità della vita dei soggetti sperimentali (15.000 adulti tra i 18 e i 28 anni), prendendo come parametri di riferimento quoziente intellettivo e densità demografica del luogo di residenza, così da valutare l’incidenza dell’ambiente sul benessere individuale.
Da qui la teoria della felicità della savana (“the savanna theory of happiness”): l’idea di un’ inclinazione primordiale per la vita “bucolica” in un contesto agreste, convertitasi col passare dei secoli in un bisogno di “solitudine urbana” nei soggetti con un QI superiore alla norma. La premessa necessaria è che il cervello umano si sia sviluppato a prova di savana africana, un ambiente con una densità abitativa pari a quella dell’attuale Alaska rurale, in cui l’aggregazione più significativa contemplava un massimo di 150 individui e in cui la socialità, caratteristica distintiva della specie umana, era funzionale solo alla sopravvivenza e al fine riproduttivo.
Con il progresso scientifico e l’evoluzione dei costumi, tuttavia, sarebbe subentrata un’incompatibilità tra le caratteristiche biologiche dei corpi e l’ambiente per cui sarebbero stati disegnati, tra una società ultra avanzata e un apparato cognitivo incapace di reggere alla complessità di un sistema così sofisticato.
Da qui il discrimine tra i cervelloni e i meno dotati di cui sopra: solo chi è smart riesce agevolmente a riconciliare le proprie predisposizioni evoluzioniste con le esigenze del mondo moderno, elaborando strategie di autodifesa contro il caos delle grandi città e i rischi che un contesto simile comporta. Una di queste è proprio la solitudine, vale a dire il volontario sabotaggio di un social network al fine di preservare doveri inderogabili. Secondo quanto emerso dall’indagine empirica dei due ricercatori, infatti, l’ancestrale attrazione per l’idillio rurale, oggi, non troverebbe più spazio negli individui con una spiccata intelligenza, capaci di plasmarsi anche alle esigenze materiali più stressanti della “big city life” e di neutralizzarle con una buona dose di asocialità.
I ritmi convulsi e la folla di stimoli che la vita metropolitana impone possono essere mitigati efficacemente dalla solitudine, uno strategico contenimento delle interazioni che agisce da meccanismo di difesa contro il malessere, consentendo di investire il tempo in modo produttivo, incanalando energie in progetti dai risvolti concreti. Lo studio riporta infatti che per i giovani più ambiziosi le dinamiche relazionali arrivano spesso a rappresentare un’imperdonabile distrazione, una trasgressione che interferisce con aspirazioni più alte e obiettivi a lungo termine.
La possibilità che la socialità venga vissuta come un insidioso ostacolo al raggiungimento di un traguardo professionale è realistica soprattutto per chi reputa il proprio mestiere una priorità assoluta (si pensi ad un medico chirurgo che investe tempo e risorse in una cura sperimentale al cancro o uno scrittore acclamato dalla critica, intrappolato nel processo creativo dell’ennesimo, pluripremiato romanzo da sfornare). Per questa categoria di persone anteporre frivolezze – come un’uscita in compagnia – ad un più nobile proposito lavorativo è una leggerezza da dribblare senza esitazioni.
Al contrario, i soggetti coinvolti con un quoziente intellettivo inferiore avrebbero mostrato una netta preferenza per la campagna e per una vita relazionale particolarmente viva: socializzare rappresenterebbe per loro una fetta di quotidianità irrinunciabile e non è affatto vissuta come una rinuncia alla produttività. Il tempo speso con amici è un momento di convivialità e di felice condivisione che migliora la qualità della vita in modo significativo, a detta degli intervistati.
Ovviamente lo studio in questione è indicativo di una tendenza riscontrata in un’indagine isolata, dunque il binarismo intelligenza-solitudine/QI inferiore-socialità non può essere assolutizzato senza ulteriori approfondimenti teorici. Non è pensabile infatti considerare una ricca vita relazionale indice scientifico di frivolezza o scarsa materia grigia, così come sarebbe inesatto associare la solitudine autoinflitta ad una convivenza frustrante con ambizioni ossessionanti.
Non si può sempre parlare di geni incompresi e di una vita appagante barattata con una dedizione “leopardiana” alla propria formazione intellettuale: solitudine si sposa spesso con un’indole genuinamente creativa, con un riconoscimento sociale ugualmente rilevante e con una comunione anche intensa con l’altro, per quanto intima e occasionale.
È bene ricordare che esiste un principio di forza nella solitudine, un’indipendenza profondamente sana e rinvigorente che mette le potenzialità individuali al riparo da fastidiose intrusioni. Da soli si può vivere in equilibrio, sperimentando la condivisione senza essere fagocitati dall’altro. Ci si può mettere in ascolto, assecondare i propri valori e vivere al loro servizio senza l’interferenza di voci altrui, di movimenti di pensiero estranei.
Ma si deve essere molto forti e ben equipaggiati per amare la solitudine. “Bisogna avere buone gambe e una resistenza fuori dal comune”, come diceva Pasolini.
Francesca Eboli
Vedi anche: Frammenti di una filmografia amorosa – Parte seconda