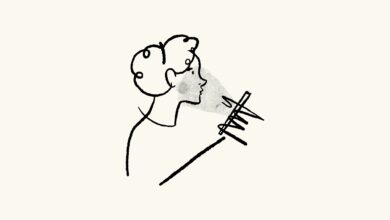La Torre, un giocatore sulla scacchiera della mafia

Nato alla vigilia della notte di Natale a Baida, un’antica frazione di Palermo, da padre palermitano e madre lucana, entrambi contadini, Pio La Torre è stato un politico e sindacalista italiano.
La sua voce me la sono immaginata più o meno così, sincera e consapevole, limpida e sicura:
Una bella carriera, impegnata a combattere per i diritti dei più deboli contro lo sfruttamento dei proprietari terrieri, a fianco dei braccianti siciliani per il diritto alla coltivazione delle terre. I miei genitori ne sarebbero stati orgogliosi.
Dal 1952 fui consigliere comunale di Palermo, poi segretario regionale della CGI e dopo essere entrato nel Comitato centrale del PCI, fui eletto segretario regionale.
Nel 1963 ottenni la carica di deputato all’Assemblea regionale siciliana per il PCI. Roma diventò la mia nuova casa. Lì mi occupai della direzione, prima, della Commissione agraria e, poi, di quella meridionale. Erano belle responsabilità.
Nel 1972 fui eletto deputato alla Camera nel collegio Sicilia occidentale, e in Parlamento continuai a occuparmi di ciò che avevo conosciuto da bambino: l’agricoltura. Era il 1976 quando entrai a far parte della Commissione Parlamentare Antimafia. Al mio fianco c’era il giudice Cesare.
Fu quello l’inizio della storia che interessa a voi, credo, anche se il vero inizio c’era già stato tempo prima.
Nel 1980 presentai alla Camera dei Deputati un disegno di legge che introduceva il reato di associazione di tipo mafioso e il sequestro dei patrimoni mafiosi.
«Noi proponiamo di concentrare l’attenzione sull’illecito arricchimento. Perché la mafia ha come fine, appunto, l’illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere i riflettori».
Ci ho provato, non ero solo.
Ho un primato: sono stato l’unico parlamentare della Repubblica ucciso dalla mafia mentre era ancora in carica. Franco e Filippo, i miei bambini, hanno addirittura voluto raccontare la mia storia. Nel 2017 hanno scritto un libro: Ecco chi sei: Pio La Torre nostro padre.
Ecco chi ero, un padre. Ecco chi sono ancora.
Mi chiamano eroe: me, che non ho mai cercato di esserlo. Parlano della mia umanità, di un genitore affettuoso e apprensivo, di un politico inflessibile e scomodo.
Di me, dicono che ho vissuto la mia battaglia – quanto si abusa di questa parola – fino a farne il senso della mia vita. Dicono che l’ho fatta talmente tanto mia, da farne addirittura il senso della mia morte. Mi chiedo se abbiano ragione.
«Il motivo per cui nostro padre poté fare quello che fece sta proprio in questa identificazione totale e piena con le sue battaglie. Oggi, come allora, queste parole possono sembrare retoriche, eppure non lo sono. Pochi hanno avuto e hanno la credibilità per pronunciarle, pochi possono davvero dire: “Io sono la mia battaglia”».
Pare che io possa dirlo, di essere stato la mia battaglia. Sono stato ucciso per la mia battaglia. Mi hanno ucciso, anzi, per quella mia battaglia, che non è mai stata solo mia.
Oggi di me rimangono incisioni e ricordi.
Una targa commemorativa a Palermo recita così: «Venivano barbaramente assassinati dal terrorismo politico mafioso due comunisti. Duri la loro memoria e l’orrore del misfatto in tutta la Sicilia degli onesti che in civile convivenza lotta per costruire il suo futuro nella giustizia, nella pace e nella libertà».
Palermo è troppo abituata alle targhe commemorative. A ogni angolo, ci sono fiori, corone, lastre di marmo, monumenti all’onore. Siamo tanti, lì, tra le strade di Palermo, a essere commemorati. Eppure qualche volta mi chiedo che senso abbia avuto morire per una battaglia, per “una cosa importante”, sussurravo a mia moglie, per cui valeva la pena vivere, ma forse non così tanto morire.
Su questo non mi è stato permesso di riflettere abbastanza. Non me l’hanno concesso. Mi hanno ucciso prima.

Erano le 9:20 del 30 aprile 1982, l’hanno scritto i giornali. Io non lo ricordo. Ero su una Fiat 131 guidata da Rosario Di Salvo, un amico, mentre stavamo raggiungendo la sede del partito.
Quando la macchina si trovava in Piazza Generale Turba, di fronte alla caserma Sole, una moto di grossa cilindrata ci intimò di fermarci. Di Salvo provò a non farlo. Continuò alcuni metri, ma non c’era possibilità. Si affiancò a noi un’altra auto. Ricordo degli uomini mascherati. Seguirono raffiche di proiettili, decine. Poi il nulla. Pare che Rosario ebbe il tempo per estrarre una pistola e sparare alcuni colpi. Io non lo vidi. E quei colpi purtroppo non gli salvarono la vita.
Oggi di me rimane una medaglia al valore. Una medaglia d’oro al merito civile, dedicata a me: «Fulgido esempio di elevatissime virtù civiche e di rigore morale fondato sui più alti valori sociali spinti fino all’estremo sacrificio».
L’estremo sacrificio l’hanno deciso altri per me. D’altra parte, è di questo che si tratta quando si parla di un sacrificio, no? Si tratta di carnefici e vittime. E per quanto possano valere le elevatissime virtù civiche e di rigore morale, io ero la vittima.
La parte che preferisco, però, la lascio sempre per ultima. «Esponente politico fortemente impegnato nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, promotore della coraggiosa legge che ha determinato una innovativa strategia di contrasto alla mafia».
Ecco quello che davvero rimane di me.
La proposta di legge “Disposizioni contro la mafia” fu tesa a integrare la legge 575/1965 e a inserire un nuovo articolo nel codice penale: il 416 bis.
Il nuovo articolo introdusse il reato di associazione mafiosa e stabilì la decadenza per gli arrestati dagli incarichi pubblici ricoperti e la confisca dei beni riconducibili alle attività criminali perpetrate.
Una volta approvata, la proposta è divenuta la pietra miliare dell’azione di contrasto dello Stato contro la mafia, nota come Legge Rognoni-La Torre (legge 13 dicembre 1982 n. 646).
Questo rimane di me: una legge che porta il mio nome. E io ancora mi chiedo di chi fosse quella che considerano la mia battaglia.
Stefania Malerba
Leggi anche: Rita Atria, il coraggio contro la mafia