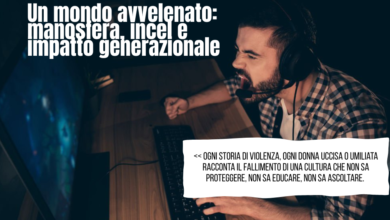White Noise, tu cosa fai per non sentire la paura?

White Noise è l’ultimo film diretto dal regista Noah Baumbach e disponibile su Netflix a partire dal 30 dicembre, basato sull’omonimo romanzo di Don DeLillo del 1985.
Con protagonisti Greta Gerwig ed Adam Driver, rispettivamente nei panni di Babette Gladney e di suo marito Jack Gladney, White Noise, perfetto esempio di cinema postmoderno, ritrae emblematicamente le logiche affettive e culturali, la schizofrenia mediatica, surreale del tardo capitalismo anni Novanta-primi anni del Duemila.
Psicofarmaci, terapie sperimentali, Elvis ed Hitler, catastrofi ambientali, malattie, supermercati con le loro infinite e rassicuranti corsie che diventano antidoto alla paura suprema; il terrore della morte è ovunque, ed impercettibilmente, come un rumore sordo, cerca di farsi strada tra i pensieri.
Ma se questo rumore è ovunque, non puoi sentirlo per davvero, o comunque puoi sempre scegliere di coprirlo, ed è esattamente questo lo scopo del rilassante e confortante rumore bianco delle fantasmagorie capitaliste, dei miti collettivi forgiati ad hoc per occultare quel vuoto che rimane.
Un rumore indistinto, costante, incessante, caratterizza quasi ogni scena del film, le voci e le parole dei personaggi si sovrappongono, le notizie date dai media sono assolutamente contraddittorie, le tragedie trasmesse al telegiornale diventano esse stesse un film, la nube tossica che diventa spettacolo metereologico, la tragedia trasformata in bellezza; poi c’è il silenzio, ci sono le coperte e c’è il Dylar.
I momenti di pausa dal rumore bianco costante sono quelli in cui i protagonisti si ritrovano faccia a faccia con la verità di un malessere inspiegabile eppure troppo familiare, in cui fanno i conti con quell’ansia primordiale che non ha un nome e per combatterla abbiamo costruito un’infinita rete sovrastrutturale di miti, significati e credenze a cui neppure gli addetti ai lavori credono più, come le suore dell’ospedale che soccorrono la coppia di protagonisti.
Il film sembra riecheggiare le teorie sul postmoderno del critico americano Fredric Jameson, a partire dalla sua struttura che sembra estendersi tutta orizzontalmente, tutti gli elementi in gioco sembrano muoversi e restare sulla superficie di un Reale che sembra risolversi in un collage di immagini, stili di vita, fotografie, citazioni e notizie allarmanti.
I dialoghi e il montaggio riescono nell’impresa di ritrarre la schizofrenia e l’isteria affettiva da XXI secolo; discorsi che si muovono tra il banale e il prosaico, l’assurdo e il no sense, non c’è alcuna consequenzialità tra le battute che sembrano invece lanciate lì solo per dire la propria pur non avendo una reale opinione su un certo argomento. Non c’è una reale comunicazione tra i personaggi, pur vivendo essi in un’epoca che fa dell’interconnessione costante la sua cifra distintiva.
D’altra parte è questo il compito dei media, intrattenere, distrarre dal costante senso di vuoto ed angoscia e dalla reale incomunicabilità che ci circonda, ma soprattutto distribuire opinioni ready made, pret à porter a chi non le abbia.
Gli effetti di questa sovrapproduzione culturale mediatica sono comunque abbastanza evidenti, più che chiarire le idee e portare l’informazione nel mondo, si ottiene spesso l’effetto esattamente opposto, poichè il proliferare indistinto di notizie ed informazioni spesso in contraddizione tra loro e non sempre qualitativamente attendibili non può non generare inevitabilmente anche confusione, disorientamento e sicuramente anche disinformazione.
Tutto ciò viene mostrato in modo esemplare dal film che sembra, a tratti, la rappresentazione di un’enorme polifonia disfunzionale, a partire dal nucleo intimo della famiglia, definita, non a caso, ironicamente (ma neanche troppo) dallo stesso Jack, “la culla della disinformazione mondiale”.
Sui personaggi di questa non così assurda storia, le cui vite scorrono tranquille tra le scintillanti corsie del supermercato, le strade luminose e la pace domestica, incombe continuamente un senso di minaccia, di pericolo, di catastrofe; tanto che, come dirà Murray, l’amico e collega di Jack, nel momento di caos e panico collettivo dovuto all’evacuazione della città, queste atmosfere di terrore risultano piuttosto familiari, come se si fossero già verificate nella nostra immaginazione.
Emblematica in questo senso la sequenza che vede alternarsi il discorso su Hitler e sulle folle del professore universitario Jack Gladney (massimo esperto negli studi sul dittatore tedesco) e l’incidente che provocherà la disastrosa nube tossica.
Sarà proprio questo incidente a mostrare quanto sia precario l’equilibrio sul quale poggiano le nostre vite e quanto in fondo abbiamo bisogno del rumore bianco, per quanto effimero sia, di credere o almeno di qualcuno che creda per noi, perché, come chiosa Jack nel malinconico ed ironico finale del film, “non c’è fine alle sorprese, mi sento triste per noi e per la strana parte che giochiamo nei nostri disastri.
Ma da un persistente senso di rovina su larga scala, continuiamo a inventare la speranza” o almeno ci si può provare, anche se è molto più semplice andare al supermercato e perdersi tra le sue deliziose corsie.
Benedetta De Stasio
Leggi anche: “The Bear”, una serie da assaporare venti minuti alla volta