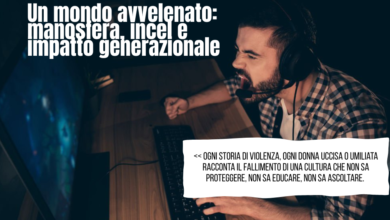La campana di vetro di Sylvia Plath: la vita che resiste

“The Bell Jar” è l’unico romanzo della poetessa Sylvia Plath, pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1963 con lo pseudonimo di Victoria Lucas, poche settimane prima del suo suicidio.
Il nome della vera autrice apparirà in copertina solo nel 1966.
Fortemente autobiografico, “La campana di vetro” è un romanzo a chiave, ossia un romanzo che narra vicende reali di persone reali, camuffate da nomi fittizi o dettagli diversi da quelli che sono loro propri per nasconderne la vera natura. È facile però riconoscere in Esther Greenwood, la protagonista, la sua creatrice. Esther è, nello stesso modo in cui lo fu Sylvia, una promettente e brillante diciannovenne della provincia di Boston, vincitrice di un praticantato a New York presso la redazione della rivista Ladies’ Day (per Sylvia fu la rivista “Mademoiselle”). Qui, immersa nell’elettrizzante caos della grande mela Esther dovrebbe divertirsi, vivere una delle esperienze migliori della sua vita, invece è «inerte e vuota come deve sentirsi l’occhio del ciclone: in mezzo al vortice, ma trainata passivamente»; la città stessa appare brutta, grigia, deludente come la realtà, diversa dal mondo e dal futuro che aveva prospettato.
Esther si sente persa, le sembra di non essere più certa di tutto ciò che aveva sempre programmato, come la carriera universitaria e di scrittrice: realizza di non saper davvero quale direzione dare alla sua vita e di non essere in grado di fare un’inevitabile scelta. È combattuta: vorrebbe conformarsi a quello che la società desidera da lei, fertile e giovane donna, ma vorrebbe anche che la vera sé, soffocata dalle aspettative di genere, emergesse. Le sembra però che ciò non sia possibile, si sente imprigionata, insoddisfatta, così si ammala e, come la nostra autrice, soffrirà di una grave depressione.
La scrittura di Sylvia Plath è diretta, tagliente, metaforica e ricca di simbolismo, ne è un esempio lampante l’albero di fico, il quale, emblema di ciò di cui Esther soffre, rappresenta tutte le strade che potrebbe percorrere – e che deve abbandonare:
«Vidi la mia vita diramarsi davanti a me come il verde albero di fico del racconto. Dalla punta di ciascun ramo occhieggiava e ammiccava, come un bel fico maturo, un futuro meraviglioso. Un fico rappresentava un marito e dei figli e una vita domestica felice, un altro fico rappresentava la famosa poetessa, un altro la brillante accademica, un altro ancora era Esther Greenwood, direttrice di una prestigiosa rivista, un altro era l’Europa e l’Africa e il Sud America, un altro fico era Constantin, Socrate, Attila e tutta una schiera di amanti dai nomi bizzarri e dai mestieri anticonvenzionali, un altro fico era la campionessa olimpionica di vela, e dietro e al di sopra di questi fichi ce n’erano molti altri che non riuscivo a distinguere.
E vidi me stessa seduta sulla biforcazione dell’albero, che morivo di fame per non saper decidere quale fico cogliere. Li desideravo tutti allo stesso modo, ma sceglierne uno significava rinunciare per sempre a tutti gli altri, e mentre me ne stavo lì, incapace di decidere, i fichi incominciarono ad avvizzire e annerire, finché, uno dopo l’altro, si spiaccicarono a terra ai miei piedi.»
Esther inizia a sentirsi sotto una campana di vetro, estraniata da tutto, in un certo qual modo protetta ma allo stesso tempo reclusa e oppressa.
La depressione sfocerà nei tentativi di suicidio e nelle conseguenti sedute di elettroshock a cui verrà sottoposta, che racconterà in tutta la loro crudeltà.
In questo illuminante capolavoro e spesso con ironia, Sylvia Plath descrive dunque la società degli anni ‘50 negli Stati Uniti, le sue ipocrisie, il ruolo delle donne, il modo in cui le malattie mentali venivano viste e sottovalutate. Saluta poi il lettore con un finale aperto, nel momento in cui dei medici devono decidere se Esther può lasciare l’istituto psichiatrico in cui era in cura.
In quel momento, in quel luogo, c’è comunque un suono che non si arresta, udibile: “I am, I am, I am” – il nostro corpo che ci ricorda di essere qui, in questo momento.
«Tirai un profondo sospiro e ascoltai il vecchio canto del mio cuore: Io sono, io sono, io sono.»
Noi siamo. Anche nel dolore.
Giulia Gennarelli
Leggi anche: Sylvia Plath, quando la tristezza genera arte