La divulgazione psicologica in pillole sui social: il problema dell’auto-diagnosi

Non avere un profilo social oggi significa non potersi connettere al mondo, rinunciare ad essere visti e ascoltati da un pubblico molto ampio.
A onor del vero, pian piano vi sono approdati i brand con le strategie di marketing, i politici con le propagande elettorali e, in ultima istanza, anche gli psicologi, con la divulgazione di contenuti scientifici.
Comunicare la scienza al grande pubblico però, è da sempre questione assai dibattuta e delicata: la sostanza si alleggerisce e il gergo scientifico si modella. Quando poi il mezzo utilizzato per la divulgazione sono i social, il lessico specialistico deve anche trovare un hashtag in cui incasellarsi e una didascalia che risulti accattivante prima ancora che scrupolosa. È per questo che ritrovarsi argomenti di psicologia -complessi e sfaccettati- a portata di click sulle nostre piattaforme social, e soprattutto pensati per un pubblico non esperto, è un fenomeno peculiare, per quanto oggi comune. Per rendere più digeribili i corposi manuali di psicologia, gli esperti li confezionano per noi in piccole dosi, che si mandano giù senza troppe difficoltà: “pillole”, per l’appunto. Lo fanno perché rendere i contenuti scientifici accessibili al pubblico, per quanto complesso, è di fondamentale importanza: la conoscenza è sempre l’unico antidoto contro le verità assolute, le affermazioni autoritarie e i pregiudizi.
I risvolti positivi della divulgazione psicologica sui social
Abbiamo già intuito che la diffusione social di contenuti relativi al benessere mentale è dunque un fenomeno controverso, per questo proveremo a metterne in luce le problematiche, ma anche i risvolti positivi. Partendo da questi, il fenomeno in questione potrebbe essere letto come la conseguenza dell’affievolirsi (seppur lentamente) del tenace tabù sulla salute mentale: armati di martello e scalpello, la Generazione Z sembra infatti essere alle prese con il tentativo di costruire una società più aperta e accogliente verso i valori del benessere e della cura del sé, smussando gli spigoli dello stigma sulla salute mentale. Pertanto, se cambia la società che produce le rappresentazione mediatiche, queste ultime non possono che cambiare insieme a lei.
Al tempo stesso, più cambiano le rappresentazioni mediatiche, più queste cambiano la società. Oltre che conseguenza quindi, la divulgazione psicologica sui social rappresenta contestualmente anche la causa dell’indebolimento dei pregiudizi sulla psicologia e sugli psicologi stessi: è piuttosto frequente oggi imbattersi in profili di professionisti che, oltre a condividere contenuti divulgativi, non ne disdegnano altri dal taglio più ironico o persino intimo, ammettendo ad esempio di recarsi personalmente in terapia per processare le frasi dei pazienti che più li hanno scossi. Così facendo, l’immagine dello strizzacervelli sulla poltrona in pelle, che ci guarda distaccato, dall’alto delle sue grosse lenti come una figura mistica -quasi non umana-, lascia spazio a quella di una persona terrena, vicina, uguale a noi. Per gli amanti della concretezza, la diffusione di questo tipo di contenuti non modifica soltanto le astratte rappresentazioni della nostra mente, ma anche i nostri comportamenti: una rappresentazione più umana e realistica della professione può infondere coraggio in chi era timoroso di iniziare un percorso di psicoterapia, sdoganando l’accesso alle cure.

Gli elenchi di sintomi e il problema dell’auto-diagnosi
Non è complicato però intuire che più un contenuto è complesso e delicato, più lo è la sua trasposizione in una forma che risulti comprensibile al pubblico e soprattutto, la sua divulgazione in un ambiente diverso rispetto a quello in cui è nato: tra le pareti di uno studio di psicoterapia, i concetti sono liberi di muoversi, evolvere, espandersi: abitare quello spazio in tutta la loro tridimensionalità. Il problema sorge quando aprono le finestre e cominciano a volare fuori, per andare a spiaccicarsi sullo schermo bidimensionale dei nostri cellulari. È proprio così che rischiano di perdere una dimensione, quella più importante, la profondità. Chiunque diffonda informazioni sui social, a prescindere dalla professione specifica, si piega infatti inevitabilmente alla logica delle piattaforme: quella della semplificazione, dell’engagement (coinvolgimento) a scapito della completezza. Così, i disturbi mentali diventano meno tortuosi, alleggeriti purché decifrabili. Sulla stessa scia, la sofferenza si schematizza in meri elenchi di sintomi, diventando così decontestualizzata, impersonale, sconnessa dal vissuto individuale.
Ora, secondo il Mind Health Report 2024, meno della metà della popolazione globale con un disturbo mentale si rivolge ad un professionista. Chi sta leggendo in questo momento potrebbe far parte di quella metà, il che non è una colpa, perché la volontà di chiedere aiuto può essere minata dai fattori sopra descritti: lo stigma, la vergogna, un’idea irrealistica della terapia e del terapeuta, sono tutti potentissimi deterrenti. Tuttavia, chi soffre ha spesso bisogno di dare un nome al proprio dolore: per quanto solitamente ci infastidiscano le etichette, appiccicarne una sui propri mali può infatti rappresentare un vero e proprio sollievo. Significa che quel disagio esiste, che riguarda anche altre persone al di fuori di noi, che c’è qualcuno che può capirci (e aiutarci). Ebbene, la ricerca di questo tipo di sollievo, coniugata con la reticenza a recarsi da un professionista, può spingere le persone a percorrere quella che, apparentemente, è la via più semplice: l’auto-diagnosi.
Ci si imbatte per caso in un post che elenca i sintomi più comuni di un disturbo depressivo e, credendo di riconoscersi nella situazione descritta, si decide autonomamente di battezzare così il proprio disagio. Il problema è che non spetta a noi scegliere quel nome: esattamente come accade per i problemi di natura fisica, anche quelli mentali necessitano di essere diagnosticati da professionisti che, per arrivarci, non si limitano a considerare i sintomi che proviamo, ma li contestualizzano nella nostra esperienza di vita. In caso contrario, come spiega accuratamente il giornale State Of Mind, l’auto-diagnosi –che non ha nessuna garanzia di essere esatta- potrebbe:
“Compromettere in diversi modi la salute del prossimo, promuovendo interventi dannosi, confondendo sull’accesso alle giuste cure di cui si potrebbe necessitare, o addirittura stigmatizzare il malessere che rischierebbe di non essere portato alla luce”
La nascita di una contro-tendenza: cosa NON è un disturbo
Il fatto che il problema dell’auto-diagnosi sia correlato alla logica di semplificazione social, non significa però che bisogni smettere di utilizzare questo mezzo per fare divulgazione, o che il format dei contenuti sopra descritti vada abolito. Tuttavia, si possono fornire agli utenti gli strumenti giusti per leggere tali contenuti in modo da non confondere la descrizione della sintomatologia di un disturbo mentale, con una quantità di informazioni sufficiente ad (auto)determinare un giudizio clinico.
Insomma, il problema della divulgazione psicologica “in pillole” sui social, non sono le piccole dosi in sé, quanto il fatto che, se assunte con poca cautela, queste possono andare di traverso. È proprio su questa cautela, dunque, che bisogna agire, ed è proprio in questo verso che ultimamente sembra dirigersi la comunicazione social di psicologi e portali di psicologia. Sembrerebbe infatti star nascendo una contro-tendenza, proprio in risposta a questa crescente e oramai riconosciuta abitudine di auto-analizzarsi: invece di fornire schede-descrizione di sintomi e disturbi, rivelatesi appunto insidiose, si propone piuttosto all’utente una lista di tutto ciò che non descrive un disturbo mentale.
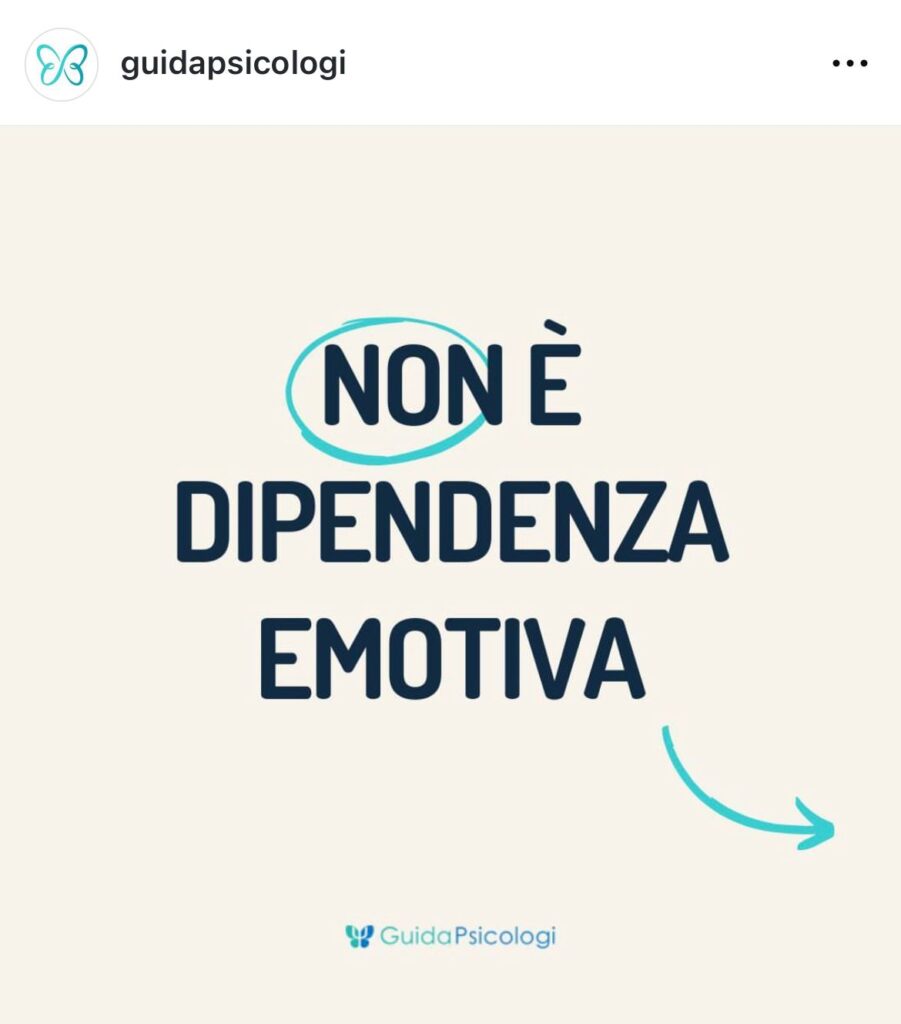
Il messaggio che fa capolino tra le pagine di questo carosello di GuidaPsicologi ha un tono rassicurante verso tutti coloro che si sono auto-convinti di avere una dipendenza emotiva. Vuole essere un abbraccio agli utenti, un’attestazione di responsabilità da parte dei professionisti della mental health, che pure (e soprattutto) sui social, non possono mettere da parte l’etica professionale e la cura verso il benessere degli utenti, vicini e lontani, pazienti e non. Qualcosa come: “Hey, se credevi di avere una dipendenza emotiva solo perché cerchi conforto nel tuo partner nei momenti difficili, sappi che non è così”.
Come questo, tanti altri sono gli esempi, anche dal tono diverso, magari ironico, ma altrettanto incisivo.
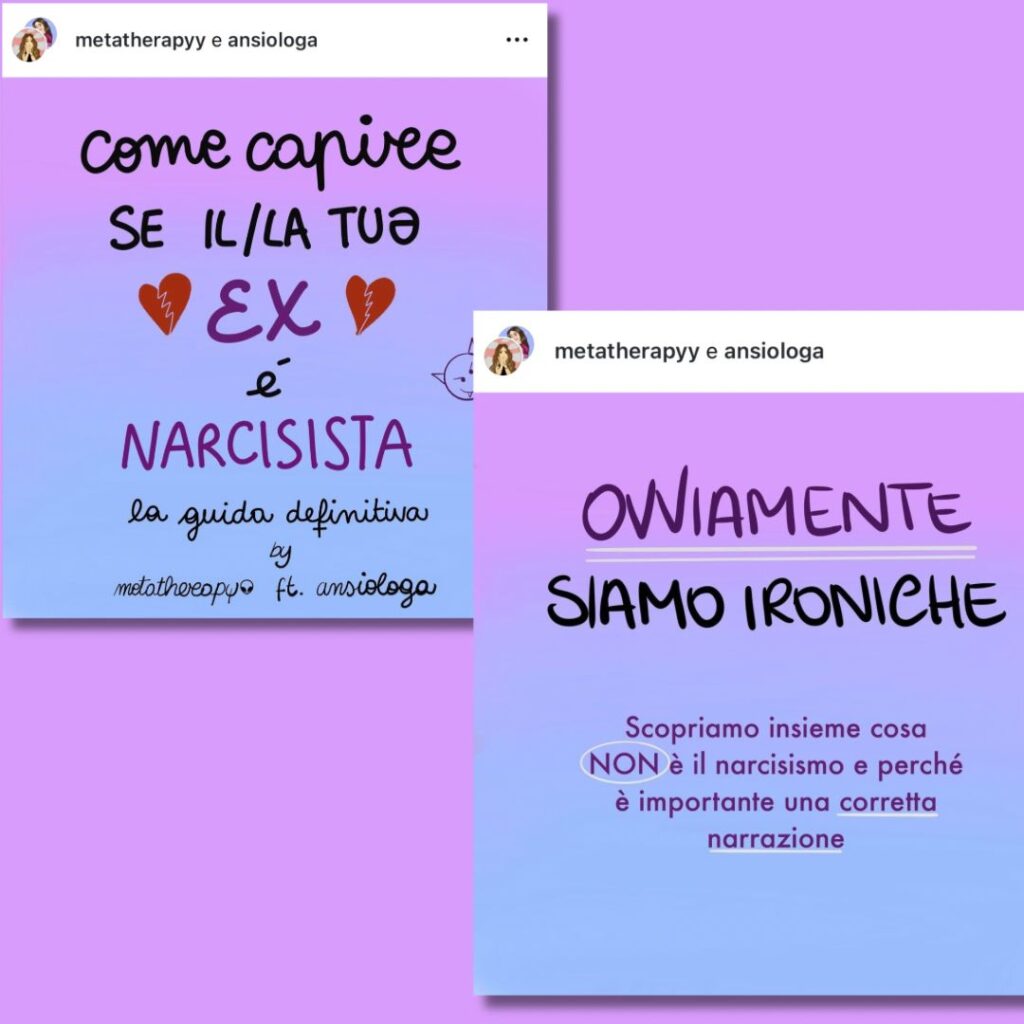
Conclusioni
La nostra società appone un pesante carico di vergogna sulla decisione di chiedere aiuto quando la sofferenza è invisibile, perché “vedere per credere” è il suo modus operandi, apparentemente da tempo immemore. Poi di tempo ne è passato, sono nati i Social Network e ci hanno offerto una (pseudo)scorciatoia, un’alternativa che richiede meno energie ma, soprattutto, meno tempo. Ci hanno abituati ad una velocità che oramai sembra applicarsi a tutti gli aspetti della nostra vita. Anche a quelli che, con la velocità, non c’entrano proprio nulla: come elaborare il dolore e lavorare su se stessi. Forse è anche per questo, che preferiamo farci guidare da un contenuto social, piuttosto che chiedere il parere di qualcuno che potrebbe davvero aiutarci. Perché questo tempo a cui siamo abituati, quello veloce, quello che non basta mai, non si può applicare alla dimensione della psicoterapia.
Una dimensione insolita, in cui il tempo scorre diversamente: il ticchettio dell’orologio è più lento, i minuti più distanti gli uni dagli altri. Perché il tempo che ci serve per processare, per accettare, per guarire, non è quello veloce, è quello dell’attesa, quello della pazienza (quello che i Social Network e la tecnologia digitale hanno seppellito). Non possiamo cliccare X se non otteniamo risultati immediati, come faremmo con la pagina di quel sito che ci spazientisce perché impiega troppo tempo a caricarsi.
Allora chiudiamo con un piccolo esercizio: al termine di questa lettura, provate a cercare sul vostro cellulare la sezione dove è indicato il tempo di utilizzo, cioè quello che trascorriamo sul dispositivo –e sui Social Network– durante la giornata. Ebbene, se come me vi siete stupiti osservando il numero di ore, e se quando pensate alla possibilità di andare in terapia tutto ciò che vedete è il tempo che scivola dalle mani, provate a ricordare che forse basterebbe soltanto un’ora tra quelle.
Soltanto un’ora, in quella settimana frettolosa, in cui potreste volervi bene senza fretta.
Simona Settembrini
Leggi anche: Selena Gomez e WonderMind, la piattaforma di salute mentale aperta al mondo




