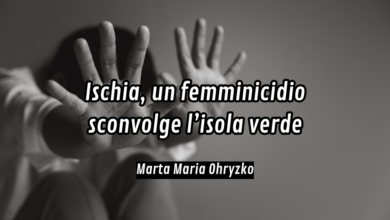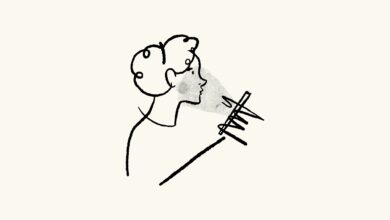Luca Giordano

Il rappresentante del barocco napoletano, conosciuto come “Luca fai presto!” per la celerità con la quale terminava le sue opere
Figlio d’arte, dimostra da giovanissimo il suo grande talento.
Si racconta che a soli 8 anni realizzò di nascosto due puttini su un affresco a Santa Maria la Nova, completando in modo esemplare l’opera a cui stava lavorando il padre Antonio. Fu mandato a bottega per ben nove anni dal Ribera, l’artista spagnolo che divenne suo mentore. Fondamentali per la sua formazione furono i viaggi a Roma, Firenze e Venezia. Il suo stile cambiò nel corso degli anni: partì dal naturalismo caravaggesco, filtrato attraverso lo studio del Ribera, entrò poi a contatto con la pittura veneta ed, attratto dagli effetti di luce e dalla varietà di colori che la caratterizzano, schiarì la sua tavolozza e la arricchì di cromie.
Le caratteristiche che lo contraddistinsero furono: abilità di mano, facilità nel memorizzare e velocità. Quest’ultima gli permise di accontentare chiunque volesse una sua opera. A tal proposito era solito dire “Ogni lasciato è perduto”. Tra le centinaia di opere da lui dipinte ritroviamo sia soggetti religiosi che laici e qualsiasi tipo di supporto. Diceva di avere tre tipi di pennelli: uno d’oro, uno d’argento e l’altro di rame, che utilizzava per soddisfare nobili, civili e plebei. Fu l’antitesi del pittore vissuto e morto in povertà, infatti la sua carriera è stata lunga e redditizia. Oltre che a Napoli, lavorò molto a Firenze, Venezia e Madrid.
“Luca fai presto” un soprannome che, è il caso di dirlo, al Giordano “calza a pennello”! L’artista era talmente veloce nel dipingere da diventare quasi una figura leggendaria. Questo suo talento incantò molti dei suoi committenti, tra i quali i reali di Spagna. La regina Maria Luisa d’Orleans, che amava osservare il Giordano mentre dipingeva, un giorno gli chiese di descrivere l’aspetto della moglie. Luca iniziò a farlo con dolci parole e nel frattempo con pochi tocchi di pennello realizzò un suo ritratto e lo mostrò alla regina, dicendole: “Eccola Maestà, questa è l’effigie della vostra umilissima serva». La regina rimase sbalordita, si tolse la collana di perle che aveva al collo e la diede al pittore come dono da consegnare alla sua bellissima moglie.
Per conquistare il re Luca Giordano oltre alla velocità utilizzò anche un’altra sua peculiare capacità, quella di imitare lo stile di altri pittori. Si narra che appena arrivato alla corte spagnola, incontrò il re e insieme andarono ad ammirare i dipinti nella galleria del Palazzo Reale. L’artista notò che, passeggiando tra i quadri esposti, il re aveva elogiato in particolare lo stile di Bassano il Vecchio. Rientrato quindi nel suo alloggio, ridipinse su una vecchia tela un quadro alla maniera del Bassano con tanto di patina finale per invecchiarlo. Dopo averlo fatto posizionare in galleria con un pretesto vi ritornò insieme al re. Carlo II inizialmente rimase interdetto, nel vedere spuntato dal nulla un nuovo quadro, e quando capì che l’artefice dell’opera era accanto a lui esclamò: “Vivas muchos años Jordanus” dandogli una pacca sulla spalla.
A Firenze
Luca Giordano lascia a Firenze, all’interno di Palazzo Medici Riccardi, splendide testimonianze del suo operato. Si tratta delle due volte dipinte per la Galleria degli Specchi e per la Biblioteca Riccardiana. Il palazzo, prima grande residenza dei Medici, simbolo del potere di famiglia e del Banco Mediceo, acquisita alla metà del Seicento dalla famiglia Riccardi, viene così arricchito secondo il gusto decorativo dell’epoca.
Ed è proprio in questo periodo – negli anni Ottanta del Seicento – che Luca Giordano interviene sugli ambienti del palazzo dando vita a due dei più importanti cicli di affreschi barocchi, che tuttora campeggiano luminosi permettendo al pubblico di apprezzare l’alta qualità e l’estro raffinato del pittore.
L’artista
Luca Giordano nasce a Napoli nel 1634, nel periodo del Viceregno spagnolo. Attraverso l’osservazione dei tantissimi autoritratti si percepisce sia l’aspetto fisico che caratteriale. Un uomo dalla corporatura esile, volto magro e pallido, un naso pronunciato, sotto al quale spesso spuntavano dei sottili baffi. Non usava mai la parrucca e nel periodo spagnolo indossava un berretto nero. Si ritrae sempre con un’espressione molto seria ed un po’ malinconica. Al contrario dell’apparenza, non era affatto un uomo triste, ma molto allegro dalla battuta sempre pronta, capace, da solo, di animare qualunque festa.
Grande imprenditore e dotato di animo sincero, non rappresentò il prototipo del pittore maledetto. Ebbe una vita tranquilla e grazie al suo talento comprò diverse proprietà, ricevette titoli onorari e lasciò una rendita cospicua alla sua famiglia. Fu sempre amabile e disponibile con i suoi discepoli, dispensando consigli e ritoccando se necessario le loro opere. La sua fama non ebbe limiti, fu amato e apprezzato da tutti, ma nonostante ciò restò sempre un uomo umile, pronto ad accogliere le critiche che riceveva. Morì il 12 gennaio del 1705, assistito dai padri di Santa Brigida, chiesa dove ancora oggi è sepolto. Ventisei anni dopo accanto a lui fu sepolta anche la moglie e nell’aprire la cassa ci si accorse che Luca impugnava ancora un pennello nella mano posta accanto al petto.
Lucia Russo
Leggi anche: Luca Giordano a Napoli: dalla Natura alla Pittura