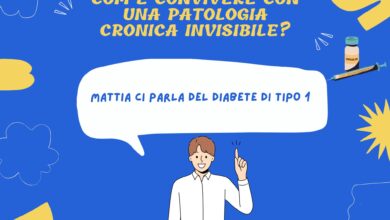Diventare grandi: un rito di passaggio mancato

L’essere umano ha sempre celebrato una serie di cerimonie che segnano il passaggio da una fase del ciclo vitale a quella successiva.
Ma che fine hanno fatto i riti di passaggio?
Abbiamo bisogno dei riti di passaggio. La nascita di una nuova vita, il battesimo, la pubertà, la patente, lasciare la casa genitoriale, la festa di laurea, le nozze, la genitorialità, la morte, sono tappe del ciclo vitale che vengono sempre in qualche modo celebrate.
I riti di passaggio sono delle celebrazioni che segnano il movimento di una persona da una condizione sociale ad un’altra, oppure da una fase del ciclo vitale a quella successiva. Continuano ad esistere, in modi e forme diverse, anche nelle moderne società capitalistiche e industrializzate. I riti non sono solo un arcaico retaggio antropologico, ma fanno intimamente parte di noi.
L’INVENZIONE DEL TERMINE
I “riti di passaggio” vengono descritti per la prima volta nel 1909 dall’antropologo francese Arnold Van Gennep, che li definì come tutte le cerimonie che segnano un cambiamento di status e una variazione dei compiti che un individuo svolge nella società. Battesimi, iniziazioni, nozze, il culto dei morti e i funerali sono alcuni esempi di rito di passaggio che si trovano pressoché in tutte le culture umane. Ma anche i riti di ingresso in un ordine religioso o quelli legati al ciclo annuale (come il capodanno, ad esempio) possono rientrare a pieno titolo nei riti di passaggio.
I riti sono dei momenti collettivi che delineano le tappe del ciclo di vita, dalla culla alla tomba, e servono a guarire le fratture che si creano lungo il corso, temporale e sociale, della vita. Sono dei veri e propri atti simbolici che permettono di passare da una fase all’altra dell’esistenza.
LE FASI DEL PASSAGGIO
Per Van Gennep il rito di passaggio si compone di tre fasi: la separazione, il margine e l’aggregazione. Prendiamo ad esempio la morte: la prima fase è rappresentata dalla veglia funebre, ossia la separazione del defunto dai viventi; la seconda rappresenta il periodo del lutto con i suoi riti (per esempio, vestirsi di nero per un determinato periodo di tempo); la terza è rappresentata dal funerale vero e proprio, in cui si celebra l’ingresso del defunto nel mondo dei morti.
DIVENTARE ADULTI, QUALCHE ANNO FA…
Il rito di passaggio più diffuso – e forse il più significativo – è il passaggio dall’infanzia all’età adulta, dalla dimensione protetta del nido familiare a quella di autonomia all’interno del gruppo sociale. Viene quindi stabilita una sorta di linea di confine tra il mondo infantile e quello adulto, momento in cui la persona si trova, a conti fatti, a costruire la propria identità, autonoma e individuale.
Fino a qualche anno fa il servizio militare obbligatorio era il rito di passaggio maschile più comune: ai diciottenni era imposto un anno di distacco dal caldo nido familiare, l’obbedienza a nuove regole di comportamento e l’assunzione totale di responsabilità – il tutto accompagnato dalla frase «il servizio militare trasforma il ragazzo in un uomo». Allo stesso modo, il matrimonio segnava il rituale preciso di ingresso nel nuovo status di famiglia.
Anche l’esame di maturità era un vero e proprio rito di passaggio, affrontato collettivamente da migliaia di studenti alla fine del percorso di studi. L’ingresso nel mondo del lavoro segnava, infine, la transizione definitiva verso una sempre maggiore autonomia economica (e di conseguenza di potere negoziale dentro la società).
… E OGGI
Ma oggi non sembra più così: nelle società contemporanee trovare dei veri e propri riti di passaggio sembra difficile. I ragazzi sono più soli e affrontano in solitudine la migrazione verso l’età adulta, senza cerimonie che ne attestino la crescita.
Fatta eccezione per l’esame di maturità – momento in cui la società cresce, collettivamente – le condizioni socio-politiche ed economiche hanno di fatto scardinato la realizzazione di questi riti di passaggio, generando forme di dipendenza prolungata dalla famiglia di origine. Così, anche dopo la maturità, si rimane imbrigliati nell’adolescenza, senza la possibilità di esprimere la propria adultità.
La leva militare non è più obbligatoria, il matrimonio è stato sostituito dalla convivenza più o meno formale o da nuove forme di vivere la coppia (come il LAT) l’ingresso nel mondo del lavoro è più fluido e parziale. Non c’è più una linea di confine tra infanzia ed età adulta.
Sono cambiati anche i costumi e il senso generazionale. Genitori e figli si vestono allo stesso modo, parlano allo stesso modo, si confidano tra loro, non producono conflitti intergenerazionali – ed ecco che il limite tra adolescenza ed adultità scompare. Non ci sono più confini chiari tra le generazioni, dramma a cui si aggiunge la cosiddetta “evaporazione del padre”, una figura che rappresentava l’autorità familiare e che aiutava i giovani a diventare adulti. Il potere paterno è stato redistribuito tra i figli, con i quali c’è un rapporto di complicità: i padri vogliono essere giovani, si atteggiano da giovani e vogliono essere sempre giovani.
Quindi si diventa giovani adulti in fretta, ma si rimane incastrati in questa tappa a lungo, per un periodo di tempo veramente indefinito.
NUOVI RITI
I riti di passaggio tradizionali sono quasi tutti spariti. Oggi si usano maggiormente gli oggetti e la cultura dei consumi per stabilire la propria adultità, primo tra tutti il possesso di uno smartphone personale. È l’uso di un prodotto, non un rito, a sancire l’iniziazione verso l’adultità. Anche l’apertura del primo profilo social è una situazione che viene vista come un vero e proprio passaggio verso l’età adulta e l’indipendenza, soprattutto tra le nuove generazioni.
Sembra che oggi i riti più importanti siano quelli legati alla carriera, alle promozioni, ai cambiamenti di ruolo e di status, alla pensione e alla crescita professionale. Siamo immersi fino ai capelli nella hustle culture.
Tra i nuovi riti c’è la modificazione del corpo che diventa una possibilità di identificazione di massa. Soprattutto tramite tatuaggi e piercing si può diventare adulti, scrivendo sul corpo storie fatte di segni e simboli, una mappa dell’esistenza. Anche il trucco e l’estetica diventano parte del processo di identificazione, non solo per le ragazze. Le unghie diventano artigli decorati, le ciglia infinitamente lunghe un prolungamento fittizio della natura, i filler e la chirurgia estetica un modo per dire “adesso sono grande anch’io”.
È una crescita che prevede un processo estremamente creativo, ma forse si ferma solo al superficiale, all’esteriore. Non sappiamo se tutti questi piccoli riti privati siano accompagnati anche da riti interiori.
Ma i riti ci servono per avere una struttura simbolica e psicologica che accompagna la nostra vita, il nostro crescere, il nostro cambiare. In un secolo di continui cambiamenti, i riti di passaggio cambiano con noi. Cambiano, non spariscono.
Elisabetta Carbone
Leggi anche: Che incubo il lavoro dei sogni