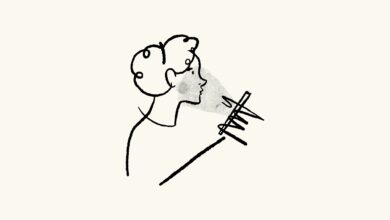Prospettive ed echi: “Lacci” di Domenico Starnone
Pochi giorni fa sono entrata in una nota libreria per effettuare un acquisto mirato di poco superiore alla decina di euro per poi ritrovarmi all’uscita – come spesso mi accade in negozi di varia natura – a fissare lo scontrino chiedendomi come fosse possibile che ne avessi spesi più di cinquanta. Ricostruire la scena del delitto non è complicato, in simili circostanze: basta muoversi tra gli scaffali e gli espositori, fossero anche solo quelli esistenti tra l’ingresso e il libro inizialmente desiderato, per lasciarsi catturare da altri titoli, altre copertine, che ci attirano a loro come il serpente il suono del flauto.
Tra i tanti volumi esposti, uno in particolare ha richiamato la mia attenzione. Lacci, di Domenico Starnone. La fascinazione è stata innescata da diversi fattori: non solo dal bel lavoro grafico a presentazione del volume, ma dal ricordo dello spettacolo omonimo con Silvio Orlando cui un paio d’anni fa non riuscii ad assistere (non ricordo più, ahimé, se per pigrizia o per forza maggiore) e, soprattutto, dalla curiosità per un autore di cui ho sentito parlare a tal punto da essermi tanto familiare quanto estraneo, come i parenti mai conosciuti nelle didascaliche litanie familiari.
Tra i libri acquistati questo è stato il primo cui abbia deciso di dedicarmi, ed ho esaurito la lettura piuttosto velocemente, per l’esiguo numero di pagine quanto per l’interesse in me destato fin da subito. In poche parole e provando a non svelare troppo, Lacci è la storia di una famiglia, della sua frattura e della sua nuova maldestra calcificazione, di un abbandono in praesentia, di un rimbombo sordo e terrificante proveniente dal passato che ci fa trasalire ad ogni sua manifestazione.
Quando iniziamo a leggere è Vanda, madre di Sandro e Anna e moglie di Aldo, a parlare, o meglio a scrivere al marito che ha abbandonato il talamo nuziale per amore della giovane e raffinata Lidia, nel tentativo di farlo rinsavire. Quattro anni di corrispondenza racchiusi in poche lettere da cui provengono nitide la disperazione, lo sdegno, la rabbia cieca di chi si sforza di capire, incapace di accettare la mancanza di un perché. La voce di Vanda viene ben presto sostituita da quella di Aldo, che conosciamo (quasi sempre) attraverso il suo monologo interiore, e allora la stessa storia ci viene raccontata da un’altra prospettiva che chiarisce le ellissi e riempie i vuoti della versione precedente. Il testimone narrativo va poi a finire nelle mani dei figli, ormai adulti, che raccontano nuovamente qualcosa di inedito o di diverso di questa storia.
Tralasciando altri grandi punti di interesse più o meno lampanti nel testo (come quelli tematici), è forse questa la grande forza del romanzo di Starnone, il gioco prospettico e geometrico per cui tutto ciò che è periferico diventa, prima o poi, centrale, tutto ciò che è sfondo incerto, nitida figura in primo piano, la progressiva presa di coscienza della verità che non esiste alcuna verità, che tutti hanno torto e ragione contemporaneamente. I rapporti tra i personaggi si disegnano e triangolano come fossero costellazioni e le voci, tutte provenienti da un’unica sorgente, compiono il misterioso miracolo di conservare in sé la traccia di quella madre comune, pur restando autonome, distinguibili, mai incidenti. Che è proprio il destino di tante famiglie legate da un’acclarata ma casuale provenienza, estranee e scontate nello stillicidio del quotidiano domestico, quello di intravedersi senza mai incontrarsi, toccarsi con violenza o non toccarsi affatto.
Francesca Grasso
Leggi anche Vita eccezionale di un uomo ordinario: “Stoner”, di John Williams