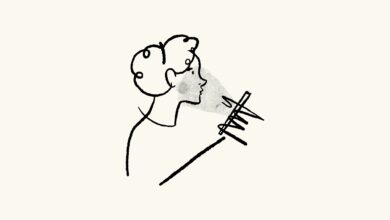Ma Rainey’s Black Bottom: il duello a ritmo di blues tra Viola Davis e Chadwick Boseman. Da Oscar

Era già nell’aria al suo debutto in streaming che questo “dramma in schermo” griffato August Wilson – nato tra i bagliori di Broadway e finito nella libreria Netflix quarant’anni dopo con George C. Wolfe alla regia – avrebbe fatto subito gola all’Academy con costumi e trucco a misura di statuetta d’oro.
Ma le possenti prove di un cast da standing ovation non sono affatto passate inosservate: il talento trasformista di una Viola Davis quasi invadente (tanto ch’è brava) nei panni dell’erotica “mother of blues” è da premiare.
E metteteci che vedere Chadwick Boseman splendere di dolore nei suoi ultimi monologhi in vita fa il suo effetto, col corpo emaciato da malato terminale strappato prematuramente alla vita e all’arte. Da Oscar.
C’è il disegno (e il portafogli) di Denzel Washington dietro questa produzione Netflix di impianto teatrale in corsa al Dolby Theatre. Uno dei tasselli del mosaico HBO Century Cycle, progetto di ampio respiro con l’ambizione di portare al cinema paradossi e idiosincrasie dell’identità afroamericana così come raccontate nel Ciclo di Pittsburgh di August Wilson, “il poeta del teatro” sull’America nera, compianto drammaturgo da premio Pulitzer cresciuto a blues e testi di Borges.
Ma Rainey’s Black Bottom è il secondo balzo dal corpus wilsoniano al grande schermo dopo Fences (2017), con cui la Davis ha già incassato un Oscar e che a questo punto sembra averci preso proprio gusto, perché la sua performance muscolare e ruggente da queen del blues non annoia neanche nelle pause sprezzanti o nei silenzi assorti in un dolore antico, un mal d’Africa ancorato a una nostalgia ancestrale. E la sua silhouette barocca, col trucco sciolto quasi gotico, i denti d’oro e le ariose movenze da tirannica diva, sa rendersi presente anche quando fuori campo, nell’attesa interminabile (direi quasi beckettiana) del suo arrivo “in scena”.
Ma riavvolgiamo il nastro: 1927, siamo nella calura estiva di una Chicago color seppia dove il soffio della musica soul e il chiasso della big city life con i suoi sfavillanti night club camuffa a regola d’arte l’orrore del ‘15-‘18 e l’imminente crollo a Wall Street che spaccherà in due il sogno americano. Ma Rainey deve incidere il suo disco: è una star del vaudeville incallita dal disgusto per le imposture della storia, pioniera di una trovata musicale tutta gemiti e voce roca che fa sgambettare anche i banchi (tanto da guadagnarsi il rispetto e le ruffianerie dell’industria yankee). Un motivo dall’anima black che “è il modo in cui parla la vita”, il suono “che ti butta giù dal letto la mattina sapendo di non essere sola”, ritmato dal fiato delle trombe e dal suo provocatorio ancheggiare. E che più tardi si presenterà al mondo come “blues” sotto il nome dei vari Louis Armstrong, Bessie Smith e Nina Simone che questa preziosa fetta d’America c’ha regalato.
Lei, domina assoluta e corpulenta, emancipata sia sessualmente che artisticamente, detta i tempi drammatici della pellicola senza scendere a compromessi, fa schioccare le labbra attorno alla bottiglia di Coca Cola ghiacciata che tracanna avidamente e non si piega alle logiche di profitto di quei visi pallidi di manager e produttore: vogliono solo spillare milioni e successo dalla sua voce tanto ruvida e piacente. Ma lei, donna selvatica e ostile alla disciplina, per anni prostituita da un sistema marcio e razzializzato, non ci sta più e ribalta i giochi di ruolo.
Dall’altro lato del “palco” una scoppiettante verbosità rumoreggia nel claustrofobico bugigattolo al piano -1 dello studio di registrazione dove la band di musicisti di Ma prova e riprova – tra guerriglie generazionali incandescenti, metafore dense di politica e struggenti memorie dal sud schiavista – i pezzi da registrare in sala d’incisione per l’ultimo disco della cantante nata in Georgia, presto in vetta alle hit parade di tutto il mondo.
Peccato che la recording session sembri non iniziare mai perché Ma tarda ad arrivare, mentre il termometro sale fino a toccare punte roventissime nello scantinato dagli arredi spogli dove le personalità debordanti dei cinque blues men battagliano fino alle urla e agli occhi iniettati di sangue. La stanza diventa così un ring, una guerra tra dimenticati marchiati dalle stesse brucianti cicatrici ma incapaci di trovare un punto d’incontro in una lotta condivisa, gli ultimi della storia intrappolati in un vicolo cieco di dolori e incomunicabilità tossica: al cheto bassista Slow Drag (Michael Potts) e al sobrio trombonista Cutler (Colman Domingo) fa da contraltare emotivo il pianista Toledo (Glynn Turman), premuroso patriarca devoto a un’etica del sacrificio, saldamente aggrappato ai sogni di gloria per il suo popolo oppresso ma figlio di una tradizione stantia che soffia in direzione opposta al vento del cambiamento.
Cambiamento caldeggiato invece dal trombettista Levee Green (Chadwick Boseman), arrogante piantagrane affamato di riscatto, dalla tempra anarchica e il sorriso compiaciuto, nonché autentico protagonista di questo capolavoro drammaturgico firmato Wilson. Un talento fresco, di indomabile esuberanza che lo spinge ad azzardare arrangiamenti non richiesti dei brani di Ma, classici intoccabili che lui sogna di stravolgere e rivitalizzare con una band tutta sua all’insegna di sonorità new wave rivoluzionarie, che facciano ballare e gioire tutta l’America, da Harlem, Chicago a Washington DC. E allora sgomita, provoca, urla e bestemmia contro un Dio crudele che non si cura del dolore della sua gente, quell’America nera calpestata dalla storia che Toledo chiama “avanzi dello stufato”, nel suo dolente monologo che più fa sussultare e commuovere, subito dopo “l’assolo” di Levee palpitante di umanità e arte purissima.
Un assolo che è un one man show indimenticabile – soprattutto se pensiamo che 12 giorni dopo quelle riprese Boseman avrebbe lasciato l’olimpo hollywoodiano orfano del suo talento ancora troppo giovane per spegnersi – dove lo spettatore scova crepe e fragilità nella maschera di giocosa spavalderia indossata da questo estroso personaggio: un omuncolo color d’ebano col corpo magro e sfregiato di chi indossa un’infanzia traumatica ancora bruciante. Un passato nel Sud del Ku Klux Klan dove a 8 anni ha assistito inerme allo stupro della madre da parte di un branco di barbari bianchi infiltratisi tra le mura di casa mentre la donna era ai fornelli a friggere pollo.
Il lavoro certosino dell’attore sul materiale di scena ha dato corpo ad un rovente monologo di rabbia compressa ed esplosa energicamente nello sguardo vibrante d’odio e nelle mani impazzite (che da solo vale la visione del film). Un ruolo pazzesco che fa già sentire la mancanza di quest’astro attoriale scomparso troppo, troppo presto, stroncato da un cancro, e che si farà fatica a dimenticare proprio come Heat Ledger col suo Joker o il Massimo Troisi de Il Postino.
Ma Hollywood sa già, si inchina al talento e lo omaggia con un Oscar come miglior attore protagonista (ma Anthony Hopkins gli soffia la statuetta). Chapeau.
Francesca Eboli
Vedi anche: Tutto il mio folle amore: Salvatores torna al road movie per raccontare l’autismo