Lehman Trilogy: l’ultima regia di Ronconi approda su RaiPlay
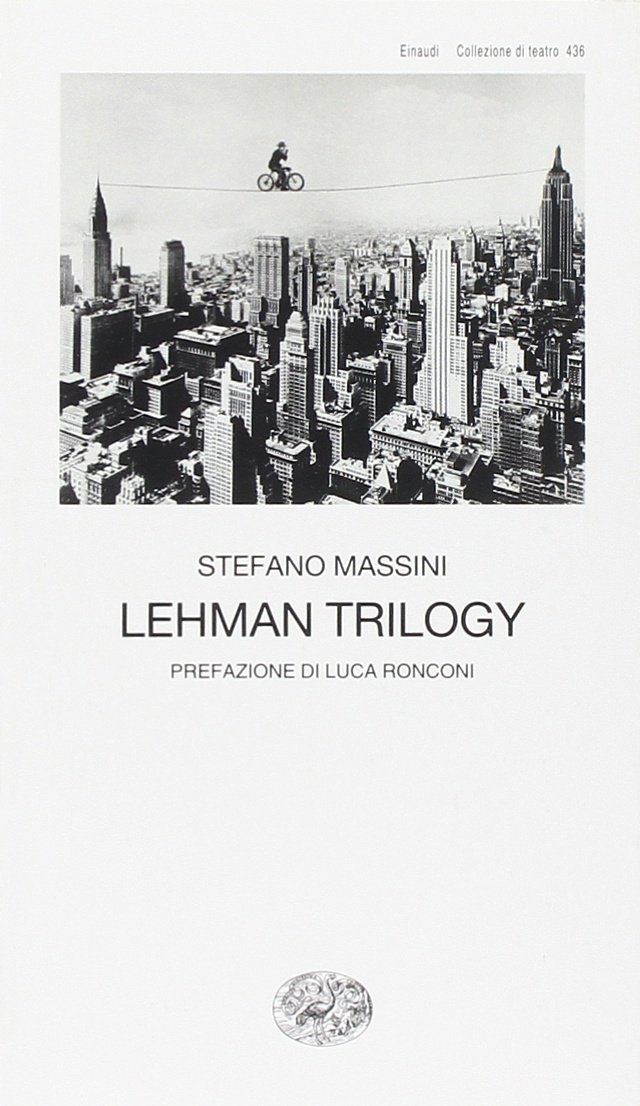
Nel 2015, prima che Luca Ronconi lasciasse il teatro italiano orfano della sua matura e superba riflessione sul linguaggio scenico, il Piccolo di Milano risuonava di applausi a sipario alzato per l’ultimo, potente sospiro creativo di questo luminare dell’arte drammatica: Lehman Trilogy.
Si tratta di un testamento grandioso, un’epopea familiare tutta al maschile che si intreccia al destino sventrato e sognatore dell’America, nazione temprata dal mito e dalle contraddizioni politiche. L’epica ricostruzione storico-letteraria di Stefano Massini è il testo su cui Ronconi, da esperto artigiano dell’artificio scenico, intaglia le sculture di carta e inchiostro della genealogia Lehman.
Vi soffia dentro vita e insane passioni, dandogli corpo, sudore, ambizione bruciante e tridimensionalità, nel titanico sforzo drammaturgico di attraversarne la vertiginosa ascesa economica, dallo spaccio di cotone grezzo dell’Alabama fino alla vendita di titoli finanziari a Wall Street, cuore pulsante di una ricchezza globalizzata, immateriale, invisibile.
E in questa reclusione forzata dell’arte, mentre la polvere si poggia sulle travi di legno dei palchi italiani ormai taciturni, RaiPlay consente eccezionalmente la visione casalinga di questo indimenticabile sold out, monumentale affresco di passioni umane lungo cinque ore e mezza, diviso in due episodi.
E nonostante la notevole prova attoriale di un cast d’eccezione (Massimo De Francovich, Fabrizio Gifuni e Massimo Popolizio, per citarne alcuni), negare che una produzione così massiccia e impegnativa – vista per di più da un dispositivo elettronico – possa far accusare cali d’attenzione anche allo spettatore più devoto, sarebbe disonesto. Nella seconda parte, in particolare, è facile perdersi nel tentativo di districare eventi storici, tensioni familiari e catastrofi finanziarie di portata epocale, difficili da maneggiare, sintetizzare e contenere efficacemente tra le quinte di un palcoscenico.
Ma torniamo alla genesi del mito Lehman, alla traversata atlantica del trio fondatore (con una Smart Tv si gioca facile, basta schiacciare il pulsante rewind): nel 1840 i tre ebrei tedeschi lasciano Rimpar, paesino bavarese d’origine, aspettando per quarantacinque giorni la visione nebulosa del nuovo continente, il profilo di una New York City vibrante di promesse.
La scenografia minimalista, essenziale, pulita si riempie dell’ingombrante, solenne dialettica di tre teste in continuo fermento, impegnate a reinventarsi ad ogni disgrazia, a raggirare le insidie e a convertirle in profitto economico: il serafico Henry (De Francovich) è la mente pensante, inflessibile pater familias dalla parola misurata e autorevole; Emanuel (uno strepitoso Gifuni) è il braccio pronto all’azione ma spesso restio al progresso, la minaccia incalzante che popola i suoi incubi; Mayer è il “tubero” virtuoso, spirito pragmatico pronto a risolvere gli screzi, interpretato dal solito impeccabile Popolizio che non cede mai a sbavature e regala momenti di alto teatro.
La verve imprenditoriale dei tre fratelli resiste al grande fuoco delle piantagioni del Sud, alla guerra civile e al crollo dell’economia schiavista post-secessione, mutando forma e lasciandosi plasmare dai cambiamenti storici di una nazione intera, in un trasformismo ciclico che non conosce arrendevolezza. Da modesti venditori di tessuti a mediatori del commercio del cotone con le industrie di tutto il paese, fino all’attività di banchieri e trader d’assalto in quel di Manhattan. I “Lehman Brothers” risorgono dalle ceneri ad ogni appuntamento tragico con la storia americana e lo fanno superbamente, con una puntualità quasi sovrannaturale che si trasmette e si moltiplica nei geni.
Analizziamo Philip (un magistrale Paolo Pierobon): è il self-made man per eccellenza, l’ebreo riformato dal sangue americano, degno discendente dei Lehman e incarnazione di quella tracotanza eschilea che trascende la vulnerabilità dei mortali. La sua esistenza è un meccanismo cerebrale che non perdona distrazioni, un esercizio di disciplina e tecnica infallibile, come la miracolosa capacità di pescare la carta giusta in un gioco di prestigio a Liberty Street, inseguendo ossessivamente le dita svelte di un nano ciarlatano. Persino la scelta della donna da sposare diventa per lui un frigido bilancio di pro e contro, misurato dallo stampatello asettico del suo logoro taccuino.
E ancora Robert: altro erede della Lehman Corporation, bolide rombante dell’impero finanziario familiare, è il patriarca a cui tocca in sorte inchiodare l’arca durante il naufragio del sogno americano, iniziato quel giovedì nero a Wall Street e tramontato per sempre con il crack del 2008. Bob anestetizza la morte e balla fino a novant’anni, perché fermarsi è vietato: sopravvive stoicamente al New Deal, all’attacco di Pearl Harbor e alla marcia su Washington di Martin Luther King, destreggiandosi tra i cambiamenti epocali a ritmo di musica, in un twist di lavatrici, televisori, stampanti e computer.
L’epilogo è una chiamata a raccolta nell’Olimpo Lehman, una funesta convocazione dell’intera discendenza ormai in rovinosa caduta verso il fallimento: una telefonata e poi il nulla. Il drammatico crollo del marchio è la nemesi storica che il destino serba a chi osa troppo, è il filo invisibile da cui precipita Salomon Paprinskij, l’equilibrista sospeso tra i grattacieli del Financial District di New York. Quel filo così fragile, eppure resiliente, logorato dalla vertigine del rischio e teso fino a spezzarsi fatalmente.
Francesca Eboli




