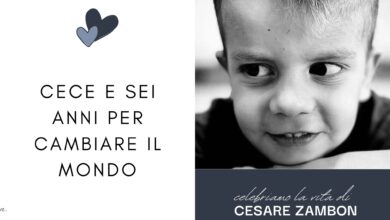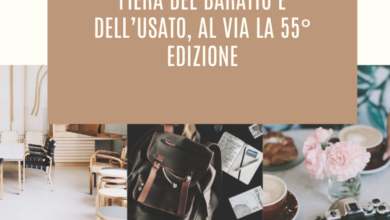L’amore eterno di Pompei: ritrovato un rilievo funebre con due sposi

Il vero amore non conosce distanze. Non si piega sotto la cenere, non si spezza contro la pietra, né svanisce nel silenzio dei secoli.
Così, tra le rovine di una Pompei congelata in un battito eterno, riaffiora una storia dimenticata, simile a una promessa che nemmeno la morte, figlia del tempo, ha saputo spezzare.
Il rilievo funebre di due sposi, uniti contro l’oblio, sembra scrutare l’orizzonte, rivolto verso lo stesso Vesuvio che, in quel fatidico giorno di ottobre, cercò di cancellarli per sempre.
Ma chi erano davvero? Quali sogni intrecciavano le loro vite prima che il vulcano, con la sua indomita furia, spegnesse ogni cosa? Insieme, in un viaggio che non conosce barriere o distanze, tenteremo di scoprirlo.
Il destino di Pompei, distrutta da uno degli eventi naturali più devastanti della storia, ovvero l’eruzione vesuviana del 79 d.C., è ormai noto a tutti, ma ciò su cui spesso si dibatte è la connotazione che si è voluto dare a questa storia; per alcuni, infatti, essa rappresenta semplicemente un drammatico racconto di morte e distruzione, così come si evince dalle lettere di Plinio il Giovane, mentre per altri, forse più inclini a cogliere significati tra le righe, assume valenze positive, per lo più relative alla resilienza umana e alla capacità di sopravvivere, persino di fronte ad un evento così tragico e disastroso.
Una vera e propria ambivalenza quindi, a cui si somma la straordinaria bellezza degli affreschi, dei mosaici e delle sculture che animano e vivificano le strade dell’antica città e che ci permettono di vivere un’emozione complessa e stratificata: morte e vita, resilienza e bellezza, passato e presente si addensano e, stringendosi in un intimo abbraccio, contribuiscono a creare un sentimento più unico che raro, molto difficile da comprendere o da spiegare. E ancora, come se non bastasse, Pompei non rappresenta certamente “un monumento fatto e finito”, quanto piuttosto un’opera che, pur rappresentando l’immobile ritratto di un’epoca lontana, rispecchia anche un sito in divenire, essendo gli scavi e le ricerche che la riguardano tutt’ora in corso.
A testimonianza di ciò, la scoperta di una monumentale tomba nei pressi di Porta Sarno, per di più ornata da uno splendido rilievo raffigurante una coppia di sposi, ha ricordato al mondo che Pompei, con i suoi infiniti tesori nascosti, è ancora capace di stupire e di sorprendere. Questo eccezionale mausoleo, emerso grazie al progetto di ricerca “Archaeology of Death in Pompeii”, appare costituito da un’ampia parete in opus incertum che, rivestita di intonaco dipinto, è caratterizzata da numerose nicchie destinate alla sepoltura e alla cremazione dei defunti. La tomba però, già straordinaria di per sé, è impreziosita dal rilievo in tufo che la sormonta e che, viste le sue caratteristiche arcaiche, suggerirebbe una datazione di epoca repubblicana: due figure ritratte frontalmente, probabilmente nell’intenzione di sottolineare con orgoglio il proprio status sociale, si distinguono per la loro delicatezza e per la cura dei dettagli, visibili soprattutto nella lavorazione delle mani, delle dita, delle unghie, nelle pieghe delle vesti e nei gioielli.
Mentre è piuttosto semplice riconoscere nell’uomo un esponente della classe senatoria, un elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla figura femminile. Oltre a indossare un corredo costituito da mantello e tunica, essa richiama chiaramente il modello iconografico della Pudicitia, molto diffuso in epoca repubblicana. Ciò che colpisce maggiormente, però, è l’aspergillum di foglie di lauro che stringe tra le mani: un dettaglio che potrebbe suggerire, sebbene non ancora dimostrato con certezza, la sua appartenenza alla classe sacerdotale. Questo strumento, infatti, era ampiamente utilizzato da sacerdoti e sacerdotesse per purificare e benedire gli spazi nel corso delle cerimonie religiose. A rafforzare questa possibile interpretazione contribuisce anche un altro elemento degno di nota, ovvero la mezzaluna pendente dalla collana che indossa, possibile indizio della sua identificazione come sacerdotessa della dea Cerere.
Nella religione romana, Cerere era strettamente legata alla luna e alla fertilità della terra, e le sue sacerdotesse, insieme alle Vestali e alle vergini Salie, erano tra le poche figure femminili ammesse al sacerdozio pubblico. Gli scavi della tomba hanno inoltre rivelato importanti dettagli sui rituali funerari riservati alla defunta. Davanti alla facciata, ad esempio, è stato individuato un livello pavimentale ricco di resti ceramici, in particolare frammenti di vasellame a pareti sottili e unguentari in ceramica, che indicano frequenti visite al luogo di sepoltura. Alla base della tomba, inoltre, è stata rinvenuta una notevole quantità di ossa umane cremate, di colore bianco, segno di una combustione avvenuta a temperature elevate (oltre i 650 °C). L’analisi morfologica dei resti ha permesso di stabilire che appartenevano proprio a una donna in età matura.
In conclusione, appare chiaro che la scoperta di questa tomba rappresenti un ritrovamento di eccezionale valore per la comprensione delle usanze funerarie, delle credenze religiose e della struttura sociale della comunità pompeiana del I secolo d.C. Gli studi, tuttavia, continuano e Pompei, come un infinito scrigno di segreti, non smette di raccontarci le sue storie ricche di umanità e resilienza.
Antonio Palumbo
Leggi anche: Le sette sentinelle di Napoli: storia, leggende e segreti di Castel dell’Ovo